Marcai nettamente la differenza rispetto ai miei coetanei, e sempre, a scuola, avrei saputo troppo rispetto a tutti, insegnanti inclusi. Però mia madre aveva le sue convinzioni pedagogiche, niente scuole speciali, si impuntò affinché seguissi il corso regolare pur essendo palesemente irregolare.
Capitava, mio malgrado, di incrociare vicini e parenti: la mia strategia era il silenzio. Mia madre non interferiva su queste decisioni. Io e lei guardavamo insieme le serie TV con poliziotti ispettori e preti e anche se io dicevo sempre come sarebbe finita lei era felice.
Lei dopo quei trentasette giorni in cui non aveva mai osato nemmeno bussare alla porta mi fissò come se non fosse accaduto nulla. Stette zitta, mi passò uno straccio sulle labbra sporche di patatine, mi strizzò due brufoli. Io lasciai fare perché sapevo che avrebbe detto qualcosa. Lei era così, aveva altre priorità. Infine parlò.
Io ci pensai. Dopo capii. Mi aveva voluto dire che come non si aspettava che nascessi così non poteva aspettarsi nient’altro. Quando ci arrivai le sorrisi e lei sorrise a sua volta distendendo i lineamenti della faccia come a dire “menomale”. Mia madre era l’unica a non avermi mai deluso. Il resto del mondo era decisamente insostenibile.
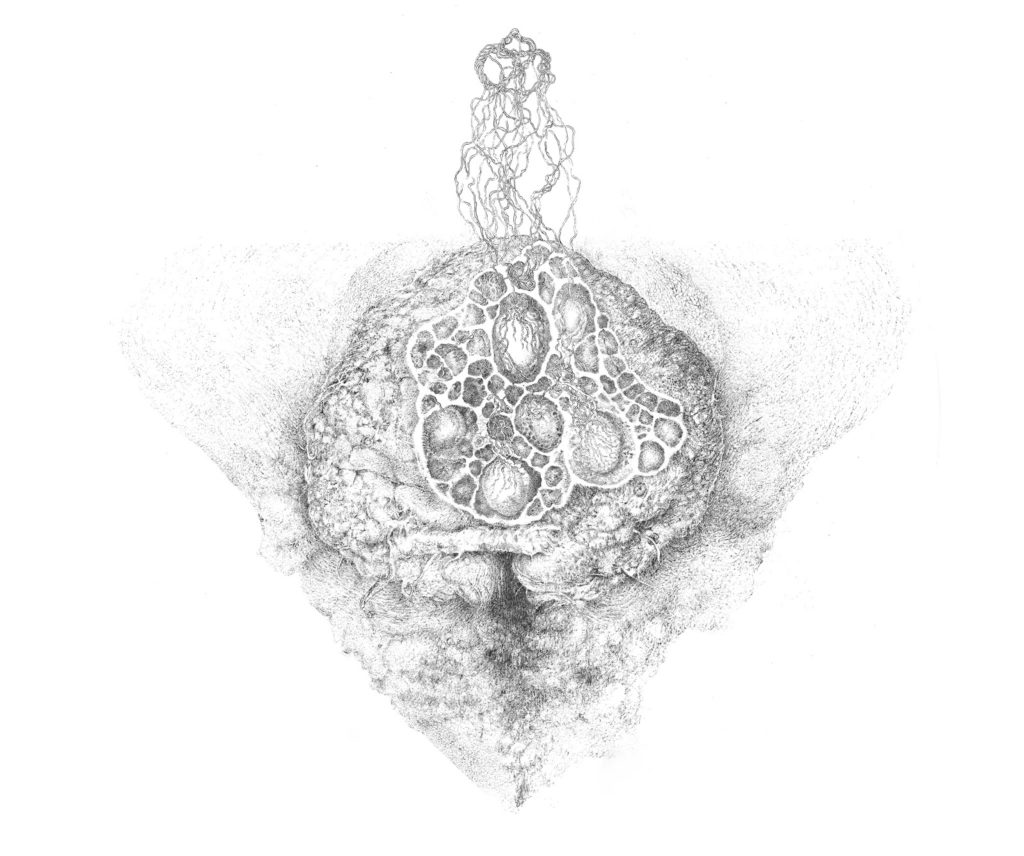
Poi c’era Margherita.
Margherita viveva al primo piano e aveva una famiglia normale, ossia un padre e una madre. Aveva la mia stessa età. Era magra come le modelle che vedevo al “Tg2 costume e società”, cioè era più magra della media tanto che in certi periodi si era sottoposta a cure perché il suo era un caso sempre ai limiti dell’anoressia con venature bulimiche. Ma sapeva recuperare subito. Si piaceva magra, Margherita, e col tempo aveva imparato a gestire il corpo senza bisogno di interventi esterni. Io durante l’adolescenza la lasciavo vomitare liberamente perché avevo imparato da mia madre che le persone devono decidere da sole, anche quando sbagliano, e infatti a un certo punto lei non vomitò più.
Margherita mi parlava sempre e solo di sé. A me andava bene così. Eravamo amici.
Quando iniziò l’università, Margherita pretese che la accompagnassi ai corsi. Io non avevo altro da fare. Mi ritrovai ad apprendere il greco e altre lingue antiche: non era divertente. Però c’era lei. Quando si avvicinava qualche ragazzo mi presentava come Will Hunting. Era un codice, voleva dire che dovevo fare come l’attore biondo nel film e cioè interrogare il ragazzo citando diversi libri che non erano in programma ma che lei mi aveva preventivamente obbligato a leggere solo per queste occasioni. I ragazzi ne uscivano malconci, Margherita rideva e così ridevo anche io.
Un giorno mi obbligò a sostenere l’esame di Letteratura Italiana dopo di lei solo perché il professore le aveva guardato le tette tutto il tempo e poi le aveva dato un voto basso.
“Stronzo pezzo di merda – mi disse – le mie tette gli facevano schifo… ora vai, tocca a te”.
Gli citai testi su Dante a lui ignoti che io e Margherita durante i corsi avevamo scelto a caso nella sterminata bibliografia dedicata al poeta sempre per il solito gioco, e quei testi fecero sudare e arrossire il professore davanti ad almeno una ventina di studenti in attesa; alla fine gli dissi che avevo dimenticato il libretto e lui alzò la voce e mi insultò alleviando così i suoi dolori. Margherita fuori l’aula rideva, rumorosamente, rideva per farsi sentire e quelle risate non erano belle.
Margherita mi diceva sempre cosa dovevo fare, era l’unica, e io lo facevo. Non mi lasciava libero e questo mi piaceva. Quando festeggiò i suoi diciotto anni mi ricordo che bevve tanta vodka poi mi portò in bagno mi obbligò a spogliarmi e a sdraiarmi sul pavimento sotto di lei, poi mi pisciò sulla faccia e mi obbligò a bere. Io lo feci. La pipì era calda e bianca e aveva un sapore che non saprei dire sgradevole ma non troppo. Ebbi un’erezione tale che appena mi sfiorò, involontariamente, con la sua mano piccola, eiaculai. Il giorno dopo lei non ricordava nulla, io invece sì. Margherita aveva capelli lunghi e lisci che spesso legava a coda di cavallo, occhi azzurri, espressione che sembrava schernire il mondo intero.
A dodici anni capii una cosa di lei. Mangiavamo un gelato. Una macchina parcheggiò, scese una signora grassottella con un bastardino di taglia piccola al guinzaglio, varcò la soglia del bar, le intimarono di non estrare col cane perché il proprietario era allergico, così lei uscì, chiese a Margherita di tenerlo pochi minuti e lei lo tenne, varcò di nuovo la soglia del bar, Margherita sorrise, guardò il cane, sorrise, davanti a noi c’era la strada, vide una macchina che si avvicinava in estrema velocità, lanciò il gelato, lasciò il guinzaglio e il resto già lo avete immaginato. Io ero dispiaciuto, la signora era più che dispiaciuta, Margherita no. Era crudele.
Margherita a diciassette anni ebbe il suo primo ragazzo. Un pomeriggio mi disse di scendere di casa alle 23.45 per farmelo vedere. La sera scesi, trovai la macchina, una utilitaria di poche pretese, ero a qualche metro quando vidi che lei teneva il membro turgido di lui tra le mani e lo leccava. Lui aveva gli occhi chiusi e lasciava fare, in stato di abbandono. Lei mi vide e mi sorrise. Io mi girai e andai via. Una volta a casa mi masturbai.
Il tempo passava e Margherita continuava con quei suoi giochi crudeli. Io la lasciavo fare, non potevo intervenire, non sarebbe stato giusto.
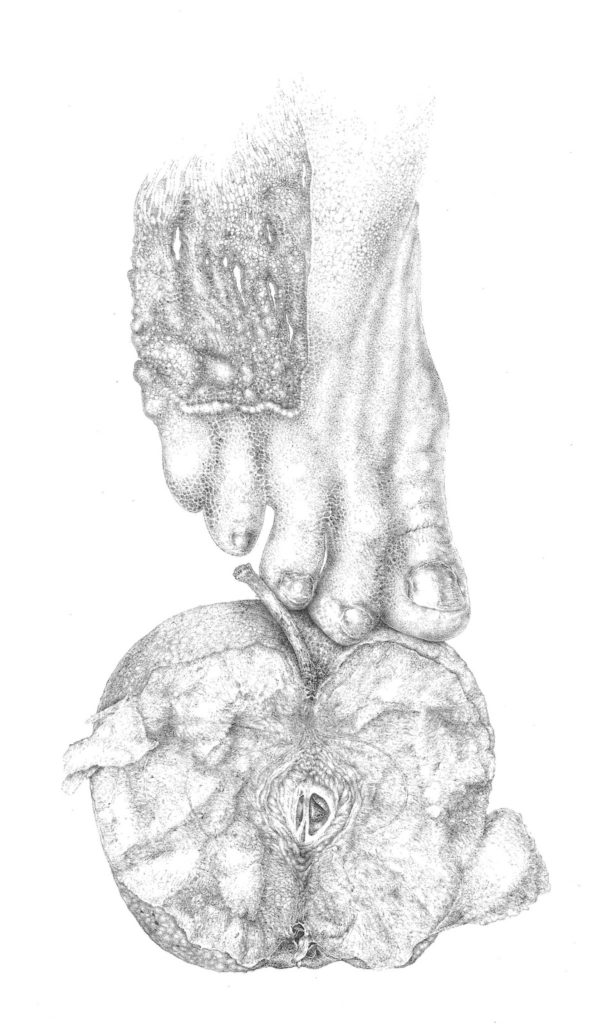
Immagini: Enrica Berselli
Una supposta nel culo. Minuscola, fastidiosa, seriale, insipida, eppure con lei che lentamente scivola sciogliendosi, impari che anche quello è tutto il tuo universo corpo. Eccetera eccetera.Piaciuto molto!(non la supposta, il testo) s.