
Parlano ancora tutti, c’è ancora tempo. Con la coda dell’occhio avverti le sagome indaffarate, uno spettacolo di dispersione cinetica. Lei tiene la mano immobile, in attesa che qualcuno le ordini di spostarla, dimostrando di essere una professionista seria, poco incline ai capricci così comuni tra le sue colleghe.Vi siete conosciuti su un altro set, qualche anno fa. Avevate entrambi una parte in una miniserie bruttina ambientata in un albergo di Ostia nel ‘68. Lei era gentile con tutti, sempre allegra, capelli inquieti e camminata da adolescente. Le poche volte che vi era capitato di parlare appariva in soggezione. Era il suo primo lavoro vero, ti aveva confessato una sera particolarmente fresca, mentre fumavate una sigaretta sul balcone dell’albergo. Ti eri sforzato di dirle qualcosa, qualcosa di utile, o almeno di carino, ma alla fine sei rimasto in silenzio e sei rientrato, salutandola con un cenno della testa. Oggi sospetti sia diventata una di quelle attrici che lotta con tutte le forze per nascondere il proprio narcisismo, attenta a sminuire pubblicamente talento e bellezza, coltivando una modestia tossica che alla lunga, ne sei convinto, la farà diventare insana di mente.
La differenza tra voi è che tu, da qualche tempo, hai scoperto l’impossibilità di essere un attore completo, mentre lei certamente non si è mai posta il problema. Senza dubbio più bella che talentuosa, più sorridente che simpatica, più famosa che apprezzata. Una creatura capace di vivere agilmente a pelo d’acqua, mentre tu ormai annaspi come un cervo in una piscina.
Perché tu sai bene che si può fare tutto, tranne il morto. Una montagna, un albero in mezzo a una tempesta, il colore rosso, un pollo, la schiavitù, il cielo, l’estasi religiosa, l’ultimo uomo sulla terra, un onesto tabaccaio dal passato agghiacciante, tutte le cose che ti chiedevano di interpretare durante quei laboratori di teatro che frequentavi con tenace disperazione a vent’anni, mentre sentivi ancora calda dentro di te la convinzione di poter diventare un bravo attore.
Ma tu non sarai mai un bravo attore. Anche se tanti dicono il contrario e spendono i loro soldi per guardarti e ogni tanto ti consegnano dei premi. Non lo sarai mai finché non saprai fare il morto.
Lei ti sorride, la mano ha cominciato a tremarle appena. Il direttore della fotografia le chiede ancora qualche secondo, c’è un’ombra che non se ne vuole andare dal tuo volto.
Provi a pensare a tutti i morti che hai visto in vita tua. I tuoi nonni, tuo padre, i tuoi amici, tua madre, i tuoi cugini, tuo fratello. Le loro facce di cera gialla, il loro non essere più vivi. I morti non si lasciano imitare, mentre i vivi spargono pezzi di sé ovunque, senza pudore. Il tuo lavoro, fino a poco fa consisteva nel raccoglierli, e quando ci riuscivi qualcosa dentro di te tornava al posto giusto.
La prima volta che ti è successo avevi sedici anni, la tua immagine riflessa nello specchio del bagno in casa di Marcella Benetti durante una festa, il frastuono di musica e risate che arrivava dalla stanza vicina, e tu in piedi davanti allo specchio, nudo, a eccezione del grande reggiseno color panna che ti copre i pettorali precocemente pelosi. Lo hai trovato rovistando nella cesta dei panni sporchi e senza dubbio appartiene alla madre di Marcella, dato che la figlia porterà al massimo una seconda, a voler essere generosi. Quella è la prima volta che capisci di poter raccogliere pezzi altrui e farli tuoi. Nudo, con indosso un reggiseno. Ma non è una cosa sessuale, non sei eccitato, stai recitando.
Davanti allo specchio illuminato con tre lampadine da 40 watt, una delle quali sporca di vernice bianca (il bagno è stato ridipinto da poco, si capisce dall’odore), stai provando a ricreare l’espressione e il gesto lezioso di portarsi una ciocca di capelli in mezzo ai seni che hai visto fare poco prima alla madre di Marcella Benetti, quando uno dei compagni di classe di sua figlia le ha detto, in modo sgrammaticato: “Giuro su dio che pensavo che lei era la sorella maggiore di Marcella, signora.”
Quell’espressione che la donna ha fatto con il labbro superiore, come risucchiato in bocca, la mano destra a portare il ricciolo di capelli (dei bellissimi capelli, fra l’altro, mossi ma non ricci, scurissimi) proprio sul punto in cui i seni si uniscono (o si separano, a seconda dei punti di vista), e quell’occhiata a nessuno, sopra la spalla destra, di finto (o vero?) imbarazzo; ecco, è tutto questo che tu, davanti allo specchio, nudo eccetto il reggiseno, provi a imitare, anzi a incarnare meglio che puoi, e ti sforzi di farlo durare, assaporando l’emozione che deve aver provato (reale o apparente, e tra queste due parole c’è tutto il senso del mondo), perché sei convinto che quel gesto abbia a che fare in modo spaventoso con l’idea di bellezza e santità e hai paura che nella vita potrebbe non capitarti mai più il privilegio di appropriarti di una cosa così preziosa.
Quindici anni più tardi, Camilla (il film non approfondiva mai i motivi del cambio di sesso) tornava in Italia per incontrare Athos, il figlio concepito durante quella notte. Il gesto che Camilla fa durante il picco emotivo di una scena intima in cucina, con la luce del mattino che filtra dalle tapparelle (“La fotografia rispettosa esalta, senza mai prevaricare, la delicatezza della pellicola, quasi a voler sottolineare il pudore delle esistenze tormentate dei destini in gioco”), alla fine di una violenta lite che li ha portati quasi a massacrarsi a vicenda, mentre il suo emotivamente instabile figlio le sussurra: “Sei la donna più bella che i miei occhi vedranno mai”, quel gesto che fa Camilla con i capelli è, né più né meno, quello che ti guardavi fare per la prima volta allo specchio del bagno di Marcella Benetti, quasi quarant’anni prima. Ma la madre di Marcella, allora, era viva e aveva i capelli bellissimi e le sue tette avevano riempito quel reggiseno chissà quante volte e l’universo infinito dei pensieri abitava nella sua testa. Ma il morto no. Questo morto no. I morti non hanno universi dentro, solo burroni. E ora che sei qui, con la mano tremante di un’attrice diligente che ti fluttua sopra la fronte non puoi non chiederti come si fa il morto, cosa si deve pensare, cosa sentire.

“Non credo di poter fare il morto”, dici.
“Sì, due volte. La prima volta mi aveva sparato la mafia per errore, ero una vittima innocente, come si dice. All’inizio ero impaurita, ma c’erano tante persone intorno a me, facevano i morti anche loro, quindi mi sono tranquillizzata. Per tanti di noi era la prima volta, quindi l’abbiamo presa a ridere, sai com’è. La seconda volta ero una suicida, ero appesa al soffitto con un cappio, dondolavo piano piano, indossavo una scarpa sola. Non ero spaventata, quella volta, solo un po’ annoiata.”
“Quello che posso dirti è che devi solo restare immobile, ma proprio immobile. Devi trattenere il respiro, dall’azione allo stop, è abbastanza facile. La parte difficile più che altro sono gli occhi, devi guardare un punto fisso e aspettare che io te li chiuda. Vedrai che dopo sarà tutto più semplice.”
Sei così stupida, pensi mentre le sorridi. Sei stupida e questa è la porzione di splendore che ti è concessa. Non hai bisogno di appoggiare la fronte alle pareti di casa, tu. Non ti servono punti di fuga, non senti l’eco del baratro quando cammini troppo forte, niente fori di spillo nel buio, quando ti addormenti. Tu profumi di frutta sbucciata al sole e merende in riva al lago.
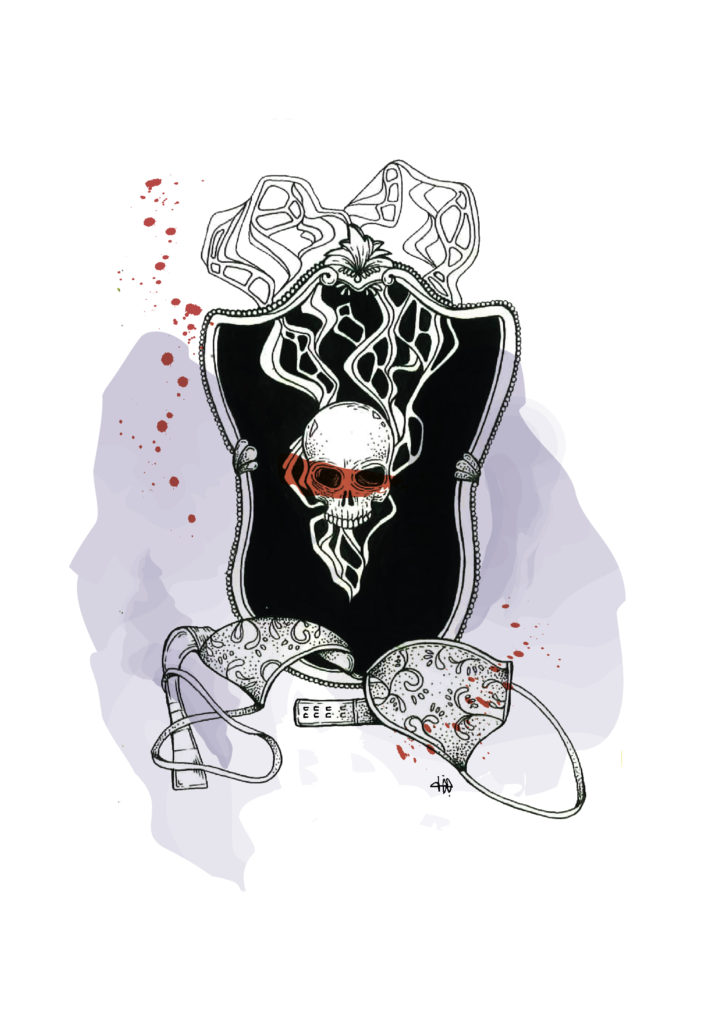
nessuno sa fare il morto, nessuno può fare il morto in maniera credibile. Per quanto si possa essere bravi, per quanto trucco si possa usare ci sarà sempre un alito di vita che renderà il tutto una farsa. Interessante riflessione, perfetta ricostruzione di un disagio insormontabile.