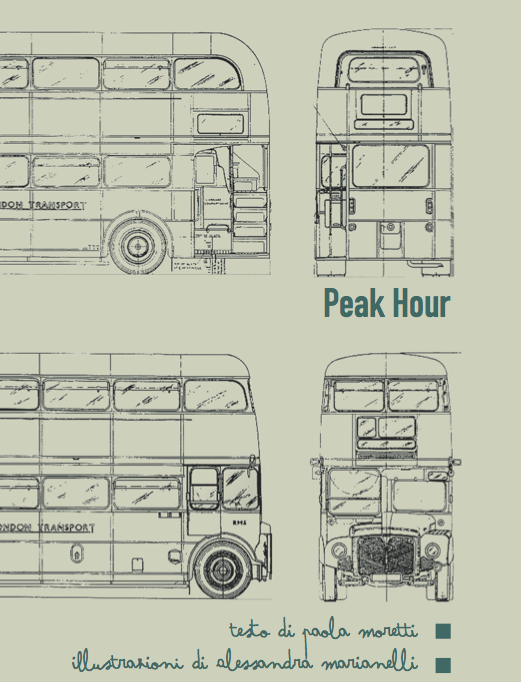
Quanto spesso vi vedete”, chiede Claudia.
“Una volta al mese? Sì, una volta al mese”, dico io.
“Da quanto va avanti?”
“Due anni, no, tre.”
Claudia rimane in silenzio, assorbe la nuova informazione.
“Tre anni?”
“Già.”
“E com’è, nel senso, come ti senti a riguardo?”
Alzo le spalle. Bene, suppongo. Ma non lo dico ad alta voce.
“Ma com’è, nel senso, la tua relazione con lui?”
Non so cosa rispondere.
“Cosa fate?”, continua a chiedermi.
“Ci vediamo, beviamo un paio di birre e poi finiamo a letto insieme.”
Si zittisce.
“Ogni tanto parliamo”, aggiungo.
Sta pensando.
“Come ti fa sentire?”
Annoiata, vuota, usata, desiderata, potente, sicura, arrabbiata, eccitata, frustrata.
“Non lo so”, dico.
“Ma cosa vuoi da lui?”
“Non lo so. Questo, suppongo.”
Mi passo la mano tra i capelli. Dovrei tagliarli.
“Ma quando parlate di cosa parlate?”
Non si arrende.
“Di casa”, dico.
Lei aggrotta le sopracciglia.
Ho avuto tante case nella mia vita. La casa in cui sono cresciuta, la casa che sono stata costretta a lasciare. La casa con il “grande amore”. La casa che mi ha accolta quando avevo bisogno di scappare. La casa che mi ha aspettata quando ero pronta per tornare. Case piene di persone, sparse in diverse nazioni.
Ripenso alle parole di Claudia. Sono una chiocciola. Il periodo di tempo che mi ci vuole per processare le emozioni dura un’eternità. Mi ritiro nel guscio appena mi sento troppo esposta. Mi porto la casa sulle spalle. Sono una chiocciola. Quante cose abbiamo in comune io e questo animale mucoso e strisciante.
“Lo ami?”
Lo amo? Non lo conosco neanche.
“Insomma, due anni è un sacco di tempo”, continua.
Due anni è un attimo.
Non mi lascia mai il cuscino più duro. Almeno il suo letto è più comodo del mio. Metto un piede ghiacciato vicino alla sua coscia.
“Non ci provare”, mi dice.
Non l’avevo neanche toccato. Mi giro.
“Ed ecco che si gira.”
Non lo capisco. Davvero. Aspetto, ferma. Magari metterà un braccio intorno al mio corpo e mi tirerà a sé. Non lo fa. Avrei dovuto portare un libro. I miei occhi non rimangono chiusi. Vagano per il monolocale. La casa è un casino, scarpe da ginnastica e skateboard sono impilati in un angolo vicino al divano, che è coperto di vestiti. Il lavandino è pieno di piatti. Le mie mutande nere sono sul linoleum opaco. Mi giro di nuovo. Lui ha un braccio sulla fronte, ma non è addormentato. Gli accarezzo il collo, lui grugnisce. Esito, lo faccio di nuovo, lui protesta.
“Mi fai il solletico”, dice infastidito.
Mi giro verso il muro. Alla fine mi addormento, ma non è un sonno profondo. Mi sveglio più volte e anche lui. Lo sento, irrequieto tra le lenzuola.
“Frittella – mi chiama la mattina – Frittella, svegliati. Esco tra venti minuti”.
Mi tiro la coperta sopra la testa.
“Non puoi stare qui”, dice.
Mugugno, poi riemergo. Lo guardo prepararsi. È un ragazzo massiccio, solido. Mi piace come la sua schiena sia perfettamente spaccata in due dai muscoli lungo la colonna vertebrale. Le sue spalle larghe. Mi piacciono le sue braccia, forti e modellate. La sua pelle glabra, caramello. Sa che lo sto guardando, ma fa finta di non accorgersene. Ha un modo strano di essere timido. Usciamo dall’edificio.
“Ci vediamo, Frittella”, mi scompiglia i capelli.
Odio quando lo fa. Ci separiamo. Sono le otto di mattina a Bethnal Green, est di Londra. Mi trovo lontana chilometri da casa e non ho ancora fatto colazione. Cammino, rintronata dal risveglio brusco e dalla mancanza di sonno. Non ne vale la pena. Frugo nella borsa alla ricerca del blister, la mano mi trema appena.
Ho conosciuto Leo quando avevo diciassette, forse sedici anni, in Italia. Me l’hanno presentato come il Rana. Veniva in vacanza al mare dove vivevo io. Anche sua nonna viveva lì. Ogni estate me lo trovavo intorno. Ha iniziato a provarci con me non appena ho raggiunto la maggiore età. Non so se per evitare di infrangere la legge o per una specie di codice morale. Ha dodici anni più di me. Nella stessa città non ci abbiamo mai vissuto, finché non mi sono trasferita a Londra, tre anni fa.
“Stavi con il tuo ragazzo prima, non avevo motivo, Pentolino”, mi ha detto quando gli ho chiesto come mai il primo anno non ci fossimo mai visti.
Grazie a dio ha smesso di chiamarmi Pentolino, anche se forse mi piaceva più di Frittella. Arrivo a casa e vado diretta in doccia. Mi strofino meticolosamente con una spugna reticolare di plastica, che se non fosse di un color pastello sembrerebbe quella per lavare i piatti.
A casa, sana e salva?, mi scrive su Whatsapp.
Qual è il senso di essere carini solo una volta che me ne sono andata? Prendo un libro dalla mensola sapendo che non farò nulla di produttivo oggi. Cool rules. Anatomia di un’attitudine. È tutta un’attitudine in ogni caso.
Sei viva?, mi scrive di nuovo la sera.
Fisso lo schermo valutando se rispondergli. Chiamo Spex.
“Mel”, dice quando risponde.
La sua voce è calda e accogliente. Non si appaia con il suo temperamento nervoso.
“Ehi”, non so cosa dire.
Starei in silenzio con il telefono premuto contro all’orecchio solo per il gusto di sapere che lui è dall’altro lato a fare lo stesso. Ci diciamo cose inutili. Io rido alle sue battute, non perché facciano ridere, ma perché sono contenta di sentirlo. Penso a come i suoi occhi scuri diventino delle mezze lune al contrario quando sorride.
“Quanti cuori hai infranto questo mese?”
“Smettila”, gli dico.
“Ti vedi ancora con il Rospo?”
“Più o meno.”
“Come sta? Salutamelo.”
Mi accarezzo la pancia, desiderando che Spex fosse vicino a me. Vive in Italia, è del mio paese. È stato lui a presentarmi il Rana.
“Come va il lavoro?”, gli chiedo.
“Al solito, sottopagato, sfruttato. Il tuo?”
“Uguale.”
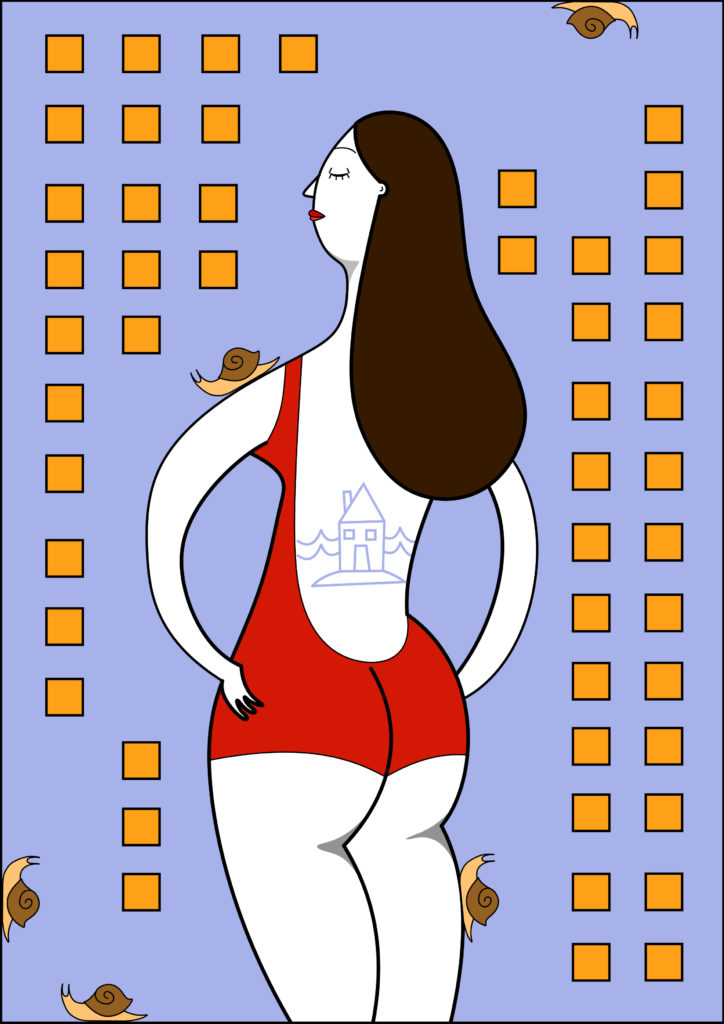
Mi sveglio e scopro che non ho niente da fare. C’è sciopero dei mezzi ed è impossibile che io raggiunga Earl’s Court, dove lavoro. Di andarci in Uber non se ne parla, spenderei la paga della giornata. A saperlo prima avrei dormito di più. Non dormo bene da settimne. Starò sul divano tutto il giorno, a leggere, a guardare film, a perdere tempo. Magari mi rilasso. Vado in cucina senza calze, briciole e polvere mi si attaccano ai piedi. Metto su il bollitore e torno in camera per le pantofole. Verso un po’ di grani di Nescafé nella tazza, non ho ancora capito qual è la quantità giusta per evitare la tachicardia.
Sto cercando di non esagerare con la caffeina. Vorrei riuscire a dormire una notte di fila, prima o poi. Vado in sala e metto il computer sulle cosce, appoggio la tazza sul bracciolo. Controllo la mail, il meteo — più tardi piove. Tanto rimango a casa. Apro Facebook, scorro le notizie. Leggo un aggiornamento di stato di Rana.
Tempo di cambiare, dice, e sotto c’è il logo della Lucas Film. Mi aveva detto di aver mandato il curriculum a Vancouver. Digito Lucas Film nel motore di ricerca. La compagnia ha una sede anche lì. Chiudo la pagina e continuo a scorrere Facebook, fingendo di non essere turbata. Prendo la tazza tra le mani e ci soffio dentro. Sarei sparita comunque. Posso finirla qua, è un bene. Sento una stretta nel petto che prova a sgretolarmi le costole da dentro. Sono libera.
Lui non è così bello, in ogni caso. Non è alto, non è magro. I suoi occhi sono troppo a palla e sporgenti. Si bagna le labbra con la lingua troppo spesso. I suoi denti di sotto sono storti. Ed è matto. Mi fa diventare matta. È meglio così. Ci siamo conosciuti dieci anni fa eppure non mi sembra di conoscerlo. Lui non sa nulla del mio passato. Io non sono in grado di anticipare le sue mosse. Mi ha detto che sono una stronza, difficile da gestire. Io penso che sia insensibile e asociale. Non ci capiamo. Siamo due misteri separati che collidono l’uno contro l’altra.
Penso di scrivergli, chiedergli del nuovo lavoro, ma non lo faccio. È lui che mi cerca più tardi.
Cosa fai?, deve essere in pausa pranzo.
Cose.
Vieni da me dopo?
Non ho tempo.
Ma se stai sempre a cazzeggiare.
Non gli rispondo. Non è da noi vederci due volte di fila. Metto la musica e mi sdraio, con le braccia incrociate sul petto. Canta Lana Del Rey. Tasto il mio seno con una mano, entra perfettamente nel palmo. Fisso il soffitto.
Una ragnatela oscilla da un uncino a cui non si aggancia niente. Il mio piede non sta fermo, si muove a destra e a sinistra senza andare a tempo. Mi alzo, vado alla finestra, cerco i passanti, ma non ce ne sono. Nessuno è a casa, come al solito. I miei coinquilini hanno una vita vera.
Arrivo, gli scrivo.
Troppo tardi Frittella, mi spiace. Ho altri piani.
Mi domando quante ragazze stia vedendo. Non riesco a immaginarmi altre donne in grado di sopportarlo. Magari con loro è diverso, dolce, per esempio.
Claudia mi sta chiamando su Skype. Temporeggio. Non so se ho voglia di parlarle, già la sento dirmi che sarebbe ora di trovarmene uno come si deve.
“Ehi”, rispondo alla fine.
“Come va?”, mi chiede.
Il video ha appena caricato, le mie occhiaie pixelate sono ancora più marcate sullo schermo. Mi parla del suo nuovo lavoro e del suo prossimo viaggio in Vietnam con il fidanzato. Sono felice per lei, ma mi annoia tutto, l’idea della sua vita. Sicura, soddisfacente, calma. È quello a cui aspiro anche io?
“Come vanno le cose con Rana?”
Eccoci qua. Potrei mentire, per una volta: “Alla grande! Mi ha portato in un ristorante romantico, mi ha preso la mano, guardato negli occhi e mi ha detto che mi ama”.
“Al solito”, rispondo.
“Mel, dovresti lasciarlo perdere, trovare qualcuno di carino.”
La sua voce è materna e autoritaria.
“Lo so”, la mia risposta condiscendente la sorprende.
La sua espressione si ammorbidisce, poi diventa intermittente, poi si blocca. La connessione internet non è un granché. Le dico che devo andare.
L’ultima volta che sono tornata al paese sono uscita con le amiche. C’era anche Claudia. Ho bevuto troppo. Quando le altre hanno deciso di andare via io sono rimasta per un ultimo bicchiere. Il barista era un amico. Mentre abbassava la saracinesca ha detto che non mi poteva riportare a casa, la fidanzata era gelosa. Anche lei era un’amica. Sono andata da Spex, abitava vicino. Mi ha aperto la porta in boxer, la faccia gonfia.
“Posso dormire qui?”
“Mel, ma porco cazzo.”
“Posso?”, le esse mi uscirono più sibilanti del solito.
Si fece da parte per farmi entrare. Mentre toglievo la giacca lo vidi sparire in camera da letto. Infilandomi sotto la coperta cercavo di muovermi piano, di fare poco rumore.
“Quanto hai bevuto?”
Non risposi. La testa mi pulsava. Sono rimasta a pancia in su a guardare il lampadario spento. Il suo respiro era diventato regolare. Mi avvicinai, appoggiai la guancia sul suo petto. Spex sospirò, mise un braccio attorno a me con la lentezza di chi è quasi addormentato. Bofonchiai qualcosa che voleva essere un grazie, gli chiesi poi se potessi dirgli una cosa, ma non ricevetti risposta.
Ho avuto il turno di mattina anche oggi. Mi sono scottata l’avambraccio passandolo sotto al lancia vapore nel momento sbagliato.
Ti va una birra dopo?, mando un messaggio a Rana.
Lavoro.
Mi sta rimbalzando. Non capisco perché tutto debba accadere alle sue condizioni. Non abbiamo mai fatto nulla di quello che ho proposto io. Più tardi vado da lui lo stesso.
Mi trucco, rimmel, ombretto. Mi metto un vestito con i fiori stampati. Gigli bianchi su sfondo viola. Steli verde chiaro. Collant coprenti cento denari. Alle sette in punto esco di casa. Spero di non beccare in pieno la peak hour. Per quando arriverò dovrebbe essere rientrato.
Scelgo il bus alla fine, l’idea di schiacciarmi in mezzo a una folla dal fiato al luppolo mi avvilisce. La corsa sembra infinita. La città scintilla in frammenti attraverso il parabrezza coperto di gocce. Piove. I fana- lini delle macchine incolonnate davanti a noi si lasciano dietro una scia rossa, come una gigantesca lumaca. Mi brontola lo stomaco.
Cammino decisa, premendo la sciarpa contro il collo, mentre il vento cerca di sfilarmela. Davanti a casa sua non esito, suono il campanello. Nessuna risposta. Suono di nuovo. Niente. Lo chiamo. Nessuna risposta. Guardo le finestre, le luci spente. Mi siedo sul gradino davanti alla porta. Fisso le macchine passare. Piove ancora. Poco. Penso a Spex.
Penso a quando siamo andati al Tube Fest, una due giorni di musica stoner rock in città, vicino al paese. “Perché si sa che le cose in Italia non vengono mai fatte come si deve. Guarda! Guarda là!”, Spex puntava il dito della mano con cui teneva il bicchiere di plastica, contro il palco. La birra rischiava di traboccare a ogni suo movimento. Indicava il sound system, silenzioso in quel momento. Riprese a funzionare dopo poco. Qualunque cosa avessi detto sarebbe stata sovrastata dalla musica, quindi non dissi niente.
Il pubblico si muoveva all’unisono come un canneto scosso dalla brezza. Ero in piedi leggermente dietro di lui, misi il braccio sopra la sua spalla e lo piegai intorno al suo collo. Lo tirai a me con delicatezza anche se la mossa aveva un che da wrestler. Avvicinai il mio viso al suo. Lui girò la testa per guardarmi, sembrava sorpreso e sicuro di sé allo stesso tempo, come se sapesse cosa sarebbe successo. Potevo vedere i suoi denti perfetti sbucare da dietro le labbra in un sorriso quasi sfrontato. Strusciai la guancia contro la sua, convinta di sentire il fastidio dei peli ispidi sulla mia pelle, ma non successe. Aprii leggermente le labbra.
“Vado al bagno”, fu tutto quello che ne venne fuori.

Seduta sullo scalino, fa freddo. L’umidità si propaga dal sedere in su. Cerco nella borsa le sigarette, ma senza determinazione. Rimesto il contenuto della sacca di tela senza afferrare niente, più che altro per avere qualcosa da fare. Poi vedo Rana arrivare. Immergo la testa nella borsa. Merda. Merda. Merda.
“Che ci fai qui?”
Pare che io abbia dimenticato come si faccia a infilare le parole una dietro l’altra. Lui apre la porta e mi fa cenno di entrare.
“Quindi?”, mi chiede.
Tolgo il cappotto lentamente, come se sembrando indaffarata fosse possibile evitare di rispondere. Lui aspetta. Mi guardo le scarpe. Si siede su uno sgabello di legno accanto a un mini-bancone che funge da tavolo da pranzo, mi fissa. O almeno immagino che lo stia facendo, perché ho ancora lo sguardo rivolto a terra.
“Non voglio che tu vada a Vancouver,” la mia voce suona come quella di un bambino che chiede scusa dopo essere stato sgridato. Sento un rumore soffocato.
“Ci tengo a te”, gli dico.
Sono sicura di essere arrossita violentemente. Lui esplode in una risata.
Finalmente lo guardo. Sta davvero ridendo. Stringo la presa intorno alla stoffa della borsa e punto alla porta. Lui continua a ridere, ma mi afferra per il polso, proprio dove la pelle è rossa e sensibile. Vorrei gridare, ma mi trattengo.
“Aspetta, aspetta.”
Sento che negli occhi si stanno formando lacrime di rabbia.
“Non vado da nessuna parte,” mi dice.
Sono confusa. Poi delusa.
“Da dove ti viene quest’idea?”
Non rispondo.
“Sei proprio scema, Pentolino.”
Mi accarezza una guancia. Non riesco a parlare. Rimango in silenzio, lui ride di tanto in tanto, come se stesse vivendo la scena in replay nella sua testa.
“Tutto ok?”
Mi scrollo la sua mano dal braccio e me ne vado. Lui non mi viene dietro. Il viaggio di ritorno sembra ancora più lungo di quello di andata. I brontolii che provengono dalla mia pancia mi ricordano che mi sono dimenticata di cenare.
Scrivo a Spex: Ci sei?
Non risponde. Appoggio la testa contro al finestrino, mi raffredda la fronte. La casa è silenziosa. Vado in camera, mi spoglio. Sprofondo nel solco del materasso consunto.
“Ho bisogno di parlare”, insisto. Spex visualizza, ma non risponde. Non c’è mai quando ho bisogno. I nervi della nuca formicolano fastidiosamente. Un ricordo che preferivo non rievocare sfreccia davanti agli occhi.
Mi stavo rifugiando nel recesso di un portone, lontano dal gruppetto di gente con le Peroni in mano. Sabato sera a Francavilla, erano tutti al baretto. La mia faccia era gonfia dal pianto. Stavo ancora piangendo quando Spex mi passò davanti. Guardava dritto davanti a sé, probabilmente cercando di individuare i suoi amici nel capannello di persone lì a pochi metri. Quando lo riconobbi misi le mani sul viso, in un tentativo scomposto di asciugarmi lacrime e naso in un colpo solo. I miei movimenti innescarono la luce a sensore, che illuminava l’entrata del condominio e qualche metro intorno.
Rmasi immobile, come un geco in piena vista che cerca di mimetizzarsi con l’intonaco. Spex si fermò, si girò, mi vide. Ero in imbarazzo, distolsi lo sguardo. Mi aspettavo che mi sarebbe venuto vicino. La luce si spense e Spex non c’era.
Ho fatto il biglietto. Chiudo il laptop. Lo so che non potevo permettermelo, ma inventerò qualcosa più avanti. Rana continua a scrivermi. Cerco di finire la mia lettura, ma non sono concentrata. Controllo il cellulare troppo spesso. Sto andando a casa. Non ho comprato ancora il ritorno, ma sospetto che non durerò più di una settimana al paese. Pensavo di essere una chiocciola. Le chiocciole non si muovono velocemente, sono calme, pazienti. Chi va piano va sano e va lontano. Il telefono vibra, è una notifica dalla banca. Spex non ha ancora risposto. È sempre così, quando ho bisogno di conforto non si palesa o taglia corto: “Sei forte, ti passerà” oppure “Sei giovane, te ne dimenticherai in fretta.”
Vorrei che per un secondo mi sollevasse il macigno dal petto, che lo tenesse su un attimo mentre riprendo fiato.
La valigia è pronta, quattro pezzi tutti neri così non mi devo preoccupare degli abbinamenti. Ho ancora tre ore prima di prendere il bus per l’aeroporto. Cammino avanti e indietro nel salotto. Scosto la tenda, osservo i passanti, cerco di dirigere la mia attenzione verso qualcuno o qualcosa.
Rana mi manda un altro messaggio: Dai, Frittella, non fare la permalosa.
Slaccio il colletto della camicia. Vado in cucina, rovisto nell’anta dei medicinali. Mi verso un bicchiere d’acqua e mando giù. Torno in sala. Il Prazene farà il suo mestiere. Mi stendo sul divano. Il telefono vibra sulla copertina molle del libro, sopra al tavolino. Gli occhi cominciano a pesare. Qualcuno mi sta chiamando. Ho sonno. L’apparecchio continua a vibrare, come lo sciabordio del mare. Le palpebre si chiudono, e nel sogno rispondo. È Spex, che mi dice di tornare.
Testo Paola Moretti
Illustrazioni Alessandra Marianelli